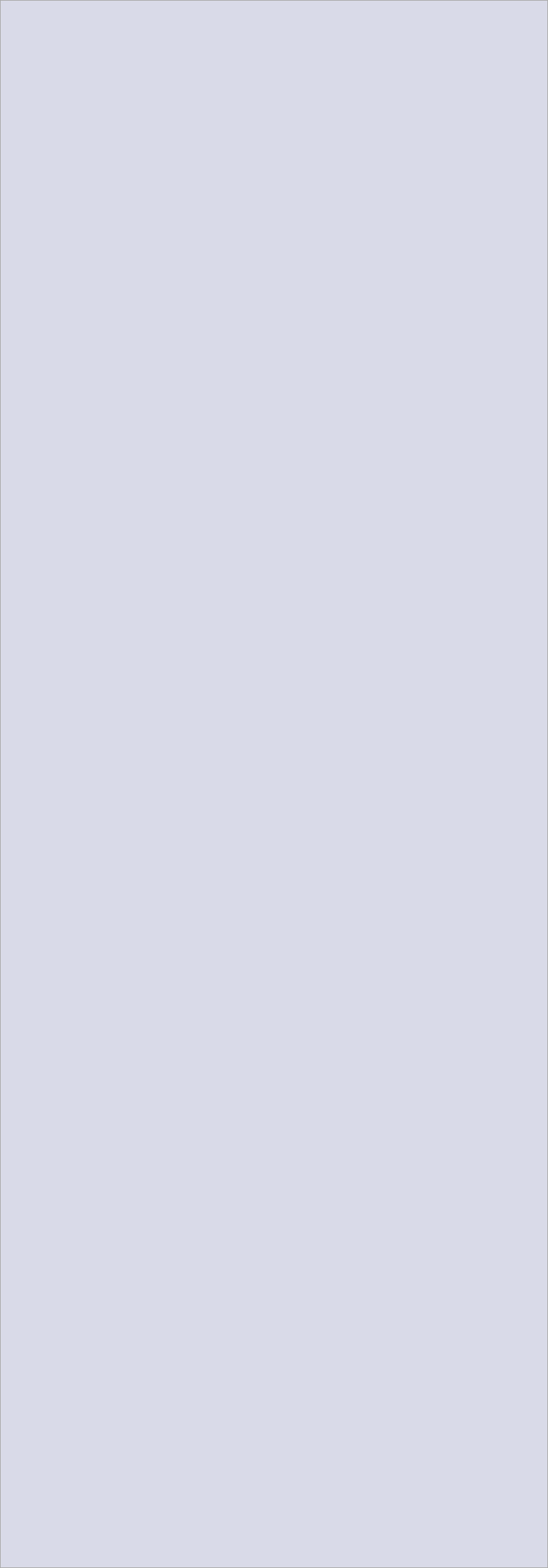
L'Associazione Nazionale della Polizia di Stato (A.N.P.S) , nata come Associazione delle Guardie di P.S., è stata eretta come Ente Morale
con Decreto Presidenziale n. 820 del 7 Ottobre 1970. La sede principale si trova a Roma in Via Statilia n.30.
Non é un' associazione di soli pensionati dell'Amministrazione. Infatti, fin dalla sua fondazione come Ente Morale, prevede l'adesione
anche del personale in servizio attivo. Creare e mantenere sempre vivo il legame di reciproca solidarietà è, appunto, suo specifico
compito. Alto, dunque, è lo scopo che l'ANPS si prefigge: di non mandare perduto il patrimonio storico-culturale creato dai Soci
"anziani", ma trasmetterlo alle nuove leve e conservare intatte le tradizioni della Polizia di Stato.
L'ANPS è custode del Medagliere, che rappresenta e rinnova il ricordo, insieme con la Bandiera, di quanti hanno offerto la propria
esistenza alla Patria in pace e in guerra, al servizio delle Istituzioni e alla salvaguardia della sicurezza e delle libertà dei cittadini.
L'Associazione si compone di Soci effettivi, benemeriti, onorari, simpatizzanti, sostenitori. Tra i Soci onorari vengono compresi i Capi e
i Vice Capi della Polizia, i Prefetti e i Questori in sede, le Medaglie d'Oro e Grandi Invalidi di guerra e per servizio appartenenti
all'Amministrazione di PS.
Sul territorio nazionale sono presenti centoquarantacinque Sezioni che si adoperano, integrate e raccordate con gli organi competenti
nelle singole materie, per risolvere i problemi sociali ritenuti via via più urgenti; nascono così le attività di vigilanza, in contatto con
le sale operative della Questura, nelle scuole per ostacolare lo spaccio di stupefacenti o le iniziative a sostegno dell'ecologia e
dell'ambiente o per la tutela del patrimonio artistico. L'ANPS è in prima linea nelle calamità naturali, affiancando i gruppi di volontari
esistenti o inserendo suoi elementi all'interno dei gruppi già attivi nei luoghi in difficoltà. Sono state altresì emanate disposizioni
categoriche a tutte le Sezioni affinché, previe intese con le Autorità Locali di Polizia (con la Polizia Stradale in particolare) e con le
autorità scolastiche, concorrano attivamente ad impartire una adeguata istruzione tecnico-pratica agli studenti dell'ultimo anno delle
scuole medie sulle norme della circolazione stradale: un deciso impegno per salvare la vita a tanti ragazzi.
Presso la sede dell'Associazione viene curato il periodico mensile "Fiamme d'Oro" inviato a tutti i soci in corrispettivo della loro
iscrizione all'Associazione. Trovano spazio su queste pagine, sempre aperte da un articolo di fondo su temi di interesse generale,
argomenti di attualità, di storia (anche riguardante la Polizia), di cultura, di diritto e a carattere professionale nonché ampi articolati
notiziari sulla vita delle Sezioni.
Vice . brigadiere P.A.I. in sahariana
La P.A.I.Voluta dal fascismo nel 1936, la Polizia coloniale (dal ‘38 con mutata denominazione di Polizia Africa italiana), all’epoca fu
considerata il “fiore all’occhiello” delle Forze del Regno per gli straordinari caratteri di modernità che riuscì ad esprimere, caratteri
ben visibili negli innovativi criteri di selezione e formazione del personale, e nelle dotazioni sia individuali che di reparto, spesso
consistenti in mezzi ed armi espressamente realizzati per quella Polizia.Fino alla caduta dell’Impero, le guardie P.A.I. furono
impiegate nelle Colonie; perdute quelle regioni divenute protettorati britannici, quei professionisti erano reintegrati nei loro incarichi
sotto le nuove autorità. A loro insaputa, nelle ex colonie i “paini” andavano anticipando quella forma di collaborazione tra le Forze
italiane e quelle alleate avutasi dall’8 settembre ‘43 nella Penisola man mano che essa veniva liberata dalle forze anglo americane.
Terminata l’esperienza in Africa, le guardie P.A.I. vennero impiegate nelle questure del Regno.Il Corpo, seppur figlio della politica
colonialista fascista, dai primi mesi del ’41, cominciava ad avvertire direttamente le disfunzioni di un organizzazione amministrativa
dello Stato che non riusciva più a mantenere le pubbliche e solenni promesse degli anni del consenso, lasciando che l’animo del
dubbio acceso dalla propaganda sempre più intensa insinuasse gli animi di quegli uomini. La Polizia coloniale da sempre legata alla
Corona, assumeva verso il fascismo una posizione dapprima “defilata” per poi divenire di aperta ostilità. Il comandante del Corpo,
Generale Riccardo Maraffa, nominato Comandante delle Forze di Polizia di Roma dichiarata “Città Aperta”, permisero allo stesso di
attuare una politica di collaborazione “debole” con le alte gerarchie tedesche, contenendo le intemperanze militari di chi si
considerava tradito. Altra figura importantissima nella storia della P.A.I. è stata quella dell’allora colonnello Sabatino GALLI, al quale,
nell’immediato dopoguerra, venne concessa la medaglia d’oro al valor Militare dal Governo degli USA per il suo contributo alla Guerra
di Liberazione.Con il nuovo corso storico repubblicano la politica estera e interna del Paese, non lasciava più spazio ad un Corpo così
fortemente orientato all’esigenze colonialiste, ma le eccellenti prove di reparto e di uomini offerte ne fecero un esperienza
fondamentale per il rifondato nel nuovo Corpo di P.S. (1945); gli uomini P.A.I. nella P.S. raggiungevano i più elevati incarichi di
comando sia di Corpo che di Reparto, quale testimonianza della formazione e capacità (gli ufficiali erano tutti laureati e reduci di più
fronti bellici) rispetto ad altro personale di P.S.. Va ricordato che fino ai primi anni ’40 il Corpo degli Agenti di P.S. era privo di
Ufficiali, fatto che favoriva le progressioni in carriera degli ufficiali già P.A.I..La “pressione “ esercitata sulle memorie dei reduci P.A.I.
fu vasta ed efficace, perdurava fino a quando erano in vita i soli che avrebbero potuto “risorgerla”: i reduci ufficiali e agenti del Corpo
di polizia coloniale.Sul piano individuale, fino ai primissimi anni ‘80, quando gli ultimissimi ex P.A.I. si incontravano in servizio e si
riconoscevano, rivivevano momenti di intensi ricordi e forse di rammarico, per non poter dar vita ai meccanismi di rielaborazione di
un passato comune, intenso, vissuto in terre lontane ed incompreso.Sul piano istituzionale, quelle rare volte che si dichiarava
l’acronimo P.A.I., era per i necrologi o saluti di commiato che Poliziamoderna riservava agli ex ufficiali coloniali.


Il Sacrario della Polizia di Stato
Forse non tutti sanno che all'Interno dell'Istituto Superiore di Polizia di Roma in via Pier della Francesca è Stato eretto il Sacrario dedicato ai nostri Caduti a partire dal 1852 fino ai giorni nostri.
Purtroppo la collocazione all'interno di una caserma di Polizia lo rende sconosciuto a molti, persino ai nostri stessi colleghi, vanificando, per certi versi, lo sforzo di tutti coloro che hanno messo moltissimo impegno nel strutturarlo, erigerlo e concepirlo. Nonostante queste difficoltà la visita a questo monumento non è certamente sprecata dato che la struttura così com'è appare esprime una fortissima carica umana e un'ottima occasione di raccoglimento e riflessione.
Poco prima di iniziare questa avventura del sito dei nostri Caduti noi della redazione ci siamo recati nella "Cappella Azzurra" , invito che estendiamo a voi tutti.
Forse non tutti sanno che all'Interno dell'Istituto Superiore di Polizia di Roma in via Pier della Francesca è Stato eretto il Sacrario dedicato ai nostri Caduti a partire dal 1852 fino ai giorni nostri.
Purtroppo la collocazione all'interno di una caserma di Polizia lo rende sconosciuto a molti, persino ai nostri stessi colleghi, vanificando, per certi versi, lo sforzo di tutti coloro che hanno messo moltissimo impegno nel strutturarlo, erigerlo e concepirlo. Nonostante queste difficoltà la visita a questo monumento non è certamente sprecata dato che la struttura così com'è appare esprime una fortissima carica umana e un'ottima occasione di raccoglimento e riflessione.
Poco prima di iniziare questa avventura del sito dei nostri Caduti noi della redazione ci siamo recati nella "Cappella Azzurra" , invito che estendiamo a voi tutti.

